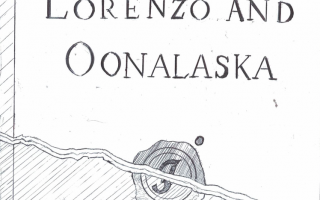di SALVATORE PANE
Non so perché, ma di questi tempi la tendenza è quella di costruire banche nei centri commerciali. Non ci sono volte, non ci sono soffitti eleganti, raramente c’è più di un solo cassiere sbadigliante. Il mio istituto finanziario assomiglia più a un negozio di cellulari o al disegno che farebbe un bambino di una banca, privo di dettagli o di qualsiasi cosa che possa ispirare anche solo un briciolo di fiducia. Non riuscivo a togliermi dalla testa questa immagine mentre ero seduto accanto a mia moglie in un’angusta banca nascosta dietro il centro commerciale di Roseville. Ci eravamo trasferiti in Minnesota nove anni prima, ma nessuno dei due era stato disposto ad abbandonare i propri conti bancari della East Coast. Solo ora, sull’orlo dell’acquisto di una casa, abbiamo deciso di aver convertirci ad una banca locale. Il consulente finanziario sedeva dietro una scrivania priva di qualsiasi tocco personale. Niente foto. Nessun soprammobile. Nessun calendario di Garfield. La donna toccò il suo tablet prima di mordersi il labbro in preda al nervosismo. “È molto importante per la banca”, ha detto, interrompendosi. “Voglio dire, è molto importante per me, per tutti noi qui, che pronunciamo il suo nome correttamente. Si dice Sail-vay-tory?”.
Le labbra di mia moglie si arricciarono e sapevo che stava cercando di trattenere le risate. Non era la prima volta che qualcuno si stupiva del mio nome da quando ero arrivato nella piatta geografia del Midwest, e non sarebbe stata l’ultima. “Sal va bene”, spiegai gentilmente. “È italiano”.
“Oh”, disse lei, incerta su come registrare questa nuova informazione. “Wow. Non l’avevo mai sentito prima”.
Crescendo a Scranton, in Pennsylvania – un’enclave di italoamericani composta da siciliani e napoletani che attraversavano l’Atlantico per lavorare nelle ricche miniere di antracite del sottosuolo – questa reazione sarebbe stata impossibile. Mio padre si chiama Sal. Mio zio si chiama Sal. Il mio bisnonno si chiamava Sal. C’era un altro Sal nella squadra di pallacanestro della mia scuola cattolica, anche se la nostra classe era composta solo da undici adolescenti pelosi e depressi. Non potevi uscire senza imbatterti in un Sal o in un Mario o in una Gianna. Le pizzerie fiancheggiavano i viali e le ricorrenze varie- lauree, matrimoni, funerali – venivano ospitate a La Cucina o a Villa Maria II o al Cataldo Club. Ogni estate si apriva con la corsa degli uomini con la statua di Sant’Ubaldo lungo le strade collinari di Jessup e culminava con La Festa, una celebrazione che chiudeva tutto il centro, con il Palazzo di giustizia invaso da bancarelle tricolori che vendevano porchetta, cannoli e lasagne. Nelle parole dell’icona di Bollywood Shah Rukh Khan, “Eravamo ovunque, tesoro”, e io credevo ingenuamente che la realtà di Scranton fosse onnipresente. Questa convinzione è rimasta anche quando ho frequentato l’università a 90 minuti di distanza e quando mi sono trasferito a Pittsburgh dopo la laurea, trascorrendo le mie giornate in quella città dei ponti ingozzando pizza da Mineo o giocando a bocce con gli anziani durante i Little Italy Days. La verità è emersa solo quando, a 30 anni, mi sono trasferito con la mia fidanzata di allora nei gelidi hinterland del Minnesota, quando ho addentato la mia prima fetta di Pizza Luce – crosta sottile come un cartone, un’unica cucchiaiata di salsa rossa senza vita, formaggio che può essere descritto solo come un insulto e una montagna di condimenti inspiegabili e francamente allarmanti – e mi sono girato verso mia moglie e ho chiesto: “Che diavolo di pizza è questa?”. Più e più volte la gente ha fatto notare il mio nome “esotico”. Più e più volte sono sceso come Dante nelle viscere bollenti di qualche ristorante che prometteva autentico cibo italiano, per poi riemergere un’ora dopo confuso, arrabbiato e affamato.
Quando sono atterrato a St. Paul, avevo già pubblicato un romanzo di formazione e altri due libri in preparazione. Ma non avevo mai scritto una sola riga sull’essere italoamericano. Vivendo sulla East Coast, mi sembrava un argomento troppo ordinario e banale, simile alla scrittura di un romanzo in cui ci si chiede se il cielo sia occasionalmente blu. Ma mentre ogni nuovo inverno cancellava il Minnesota, la mia immaginazione fuggiva verso i luoghi della mia giovinezza, sondando quelle immagini idilliache e stereotipate: la nonna con la babushka rannicchiata davanti a una pentola fumante di salsa rossa, che ballava la tarantella a un matrimonio mentre gli ospiti palpavano buste piene di soldi, le croci nere e macchiate sulla fronte mentre i fedeli evacuavano la messa. Ho scritto il mio primo racconto sull’esperienza italoamericana mentre vivevo in Minnesota. Poi ne ho scritto un altro. Poi ho viaggiato tra Milano e Torino per una conferenza di una settimana e poi, per motivi di lavoro, ho vissuto a Roma per tre mesi. Sono passati nove anni e alla fine ho pubblicato una raccolta di questo materiale, The Neorealist in Winter, contenente otto storie di italoamericani negli Stati Uniti, due di italoamericani in Italia e una di italiani in patria. Ho intrapreso un modesto tour del libro, visitando i miei luoghi familiari a St. Paul, tornando in aereo a Pittsburgh, guidando per quattro ore fino a Milwaukee; il mese prossimo parlerò a Boston. E inevitabilmente, alla fine di queste sessioni, qualche anima gentile abbastanza da sopportare una lettura si alzerà dalla sedia e chiederà: “Ma cosa significa essere italoamericani oggi?”.
Ogni volta mi scontro con questa domanda, e non mi è chiaro se questa sia una prova del successo o del fallimento di Neorealist. Mi agito e mi arrovello. Nomino il mio gatto Martin Scorsese the Cat. Suggerisco di sostituire le statue di Colombo con il fiero volto di un certo Giancarlo Esposito. Divento evasivo e vuoto, proprio come quando mi trovo di fronte ai benintenzionati impiegati della cooperativa di credito che vogliono solo riprodurre correttamente il mio nome. Ma in fondo ho un sentore. Un senso delle cose. Posso parlare solo della mia esperienza, di ciò che ho osservato, ma essere un italoamericano oggi, a un secolo di distanza da Figlio d’Italia dello scrittore Pascal D’Angelo – la sua grande opera sull’esperienza degli immigrati – è come brancolare in un labirinto di specchi.
Gli italoamericani – forse più di ogni altra comunità bianca emigrata dall’Europa – si sono quasi sempre visti riflessi nei media. L’esempio più facile è Il Padrino, l’urtext per tutti gli italoamericani. Dite quello che volete sulle rappresentazioni mediatiche della mafia, ma Francis Ford Coppola dedicando i primi 27 minuti del film al matrimonio di Connie chiarisce le sue intenzioni. Certo, la celebrazione è intervallata dal profetico “I believe in America” di Buonasera e dalle macchinazioni di carriera del crooner in declino Johnny Fontane, ma il matrimonio in sé è girato come un quasi-documentario e per quelli di noi nati dopo l’uscita del film nel 1972 o addirittura nell’ambiente del secondo dopoguerra in cui il film è ambientato, questa è la cosa più vicina a casa che potremo mai vedere.
Quante famiglie italoamericane hanno rigurgitato i rituali del matrimonio di Connie Corleone non perché si tratta di tradizioni familiari consolidate, ma perché Il Padrino ci ha fatto credere che si tratta di tradizioni familiari consolidate? Non sappiamo cosa non sappiamo, ma conosciamo Il Padrino. E conosciamo Mean Streets. E conosciamo GoodFellas. Conosciamo La febbre del sabato sera, Moonstruck e My Cousin Vinny e l’elenco continua, come non accade per la comunità tedesco-americana o irlandese.
Avevo appena tredici anni quando I Soprano debuttarono sulla HBO nel 1999. Guidato dallo showrunner David Chase – da notare come David abbia tolto il DeCesare dal suo cognome a favore del vuoto Chase – il protagonista della serie Tony Soprano lotta costantemente con la sua identità. Nell’episodio pilota, dice al suo terapeuta: “È bello essere su qualcosa dal piano terra. Sono arrivato troppo tardi per questo. Lo so. Ma ultimamente ho la sensazione di essere arrivato alla fine. Il meglio è finito”. Questo monologo, spesso citato, riflette i sentimenti di Tony nei confronti della mafia che entra nel nuovo millennio, ma è anche una metafora di ciò che molti americani hanno provato negli ultimi giorni prima dell’11 settembre e della pura follia dei due decenni successivi. Meno discusse sono le sue ovvie connessioni con l’esperienza italoamericana non criminale.
Come può un italoamericano incarnare davvero questa identità a tre o quattro generazioni di distanza dal nostro esodo europeo? Come può un italoamericano incarnare questa identità in una tundra gelata dove la gente non sa pronunciare il nome Salvatore? Come può un italoamericano incarnare questa identità quando non conosce tradizioni che non abbia osservato in televisione e non ha mai assaggiato in vita sua la pasta fatta in casa? I Soprano è uno show televisivo su mafiosi che impersonano mafiosi: Silvio dà spesso prova della sua imitazione di Pacino, mentre l’auto di Paulie Walnuts suona letteralmente il clacson del tema de Il Padrino. Questi personaggi non sono riflessi della vita reale come ne Il Padrino. Sono riflessi di riflessi. A 25 anni dalla prima della serie, questo problema si è intensificato. Anch’io sono un riflesso che imita l’eredità culturale trasmessa da altri riflessi. Una fotocopia di una copia di una copia. Siamo tutti, a nostro modo, ombre, le persone informi e contorte dello specchio del luna park, pronte e desiderose di trasformarsi.
#
L’estate scorsa mi sono recato a Palermo per terminare The Neorealist in Winter. Ho soggiornato nella villa-appartamento del defunto Giuseppe Di Lampedusa, il grande scrittore de Il Gattopardo e per giunta ex principe di Lampedusa. Ogni volta che visito l’Italia, mi lascio sedurre dalla fantasia cervellotica, ma bellissima, di ritrovare in qualche modo la mia famiglia europea. Non vedo la maggior parte della mia famiglia in America da quasi un decennio e forse è da qui che nasce tutto questo. Ho fatto ricerche sulla mia gente, li ho rintracciati nel piccolo villaggio di San Cataldo, ma il giorno cruciale della partenza non ci sono andato. Sono rimasto invece a Palermo, a bere cocktail con mia moglie e gli altri turisti. Dissi a una cameriera che i miei erano originari di San Cataldo e lei mi disse che era cresciuta in fondo alla strada. Eravamo paesani, mi spiegò con orgoglio. Incontrai un banchiere siciliano e sua moglie ucraina, e lui mi chiese davanti al vino se fossi orgoglioso del mio sangue siciliano. Quella sera, la mia ultima a Palermo, tornai alla villa trasformata in appartamento e vidi un taxi bianco decappottabile sfrecciare sul selciato vicino al Mar Tirreno. Una donna con un maxi-abito nero e svasato stava sul sedile posteriore, afferrando un corrimano installato proprio a questo scopo. Un’evidente turista, che tracannava da una bottiglia di prosecco e gridava “Woo hoo!”, mentre il tassista – nel chiaro tentativo di aumentare la mancia – suonava il clacson e inondava la strada con il tema de Il Padrino sparato a tutto volume dagli altoparlanti. Sono rimasto a bocca aperta insieme a mia moglie e abbiamo guardato il taxi scomparire nelle ombre di Palermo.
Salvatore Pane è autore di cinque libri, il più recente dei quali è “The neorealist in Winter”. Altri suoi lavori sono comparsi su Prairie Schooner, Indiana Review e American Short Fiction. È professore associato presso l’Università di St. Thomas dove insegna Cinema italiano. Il suo sito è https://salvatore-pane.com/
Leggi il pezzo in inglese cliccando qui