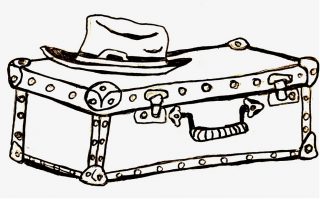di FRANCESCO CHIANESE
Dopo aver attraversato diverse edizioni e lingue – spagnolo, portoghese, tedesco, olandese – La straniera di Claudia Durastanti giunge nelle librerie dei due paesi che più a fondo hanno formato l’esperienza dell’autrice e a cui è legata la sua doppia cittadinanza linguistica, Stati Uniti e Regno Unito, tradizionalmente separati dallo stesso idioma secondo una celebre definizione di George Bernand Shaw. Dietro le copertine molto diverse delle due edizioni – quella inglese per Fitzcarraldo, uscita lo scorso 19 gennaio, ha preceduto di pochissimo la pubblicazione americana per Riverhead il 25 del mese – questo libro che si è presentato da subito come uno “shapeshifter”, secondo la definizione di Durastanti, rivive nella medesima, intensa e levigatissima, traduzione di Elizabeth Harris, sottoponendo al pubblico internazionale il racconto dell’originale diaspora della sua autrice.
La natura di libro spartiacque e complicato da classificare, emersa già al momento della sua pubblicazione in Italia, nel 2019, è confermata dal passaggio dal genere del memoir con cui si è presentato in questi tre anni di migrazioni editoriali a quello di “novel” che ha acquisito nel contesto anglofono e che ci porta direttamente alla riga finale del volume, in cui leggiamo: “ma è una storia vera?” L’oscillazione tra descrizione e invenzione nella narrazione allestita da Durastanti ha costituito un punto di forza piuttosto che una criticità per il pubblico transnazionale che lo ha accolto, in costante espansione dal momento in cui l’autrice ha sfiorato il Premio Strega alla sua prima partecipazione, piazzandosi nella cinquina finale.
La storia che Durastanti descrive nel libro echeggia in vari modi in quella dei personaggi irrisolti e dislocati che incontriamo nei volumi di fiction che hanno preceduto l’uscita di questo lavoro più esplicitamente autobiografico, in cui già riconosciamo, anche quando non è esplicita nel testo, i tratti di un’identità diasporica, costantemente sospesa tra mondi diversi: Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra (2010); A Chloe, per le ragioni sbagliate (2013); Cleopatra va in prigione (2016). Solo nel memoir tuttavia possiamo mettere insieme tutti i pezzi della puzzle diasporico di Claudia, che è nata a Brooklyn all’inizio degli anni Ottanta da genitori italiani in uno dei quartieri più profondamente connotati etnicamente da fenomeni di “etnicità densa”, Bensonhurst; è rientrata in Italia insieme ai genitori quando questi si sono separati, ricollocandosi tra Roma e la Lucania; si è quinti trasferita a Londra negli anni della maturità, dove ha vissuto praticamente fino alla pubblicazione di quest’ultimo volume, per insediarsi di nuovo a Roma nel periodo più recente. In un’unica storia, dunque, riconosciamo la complessità delle esperienze più attuali dell’emigrazione italiana, che si avvolge intorno a una molteplicità di centri e di esperienze, risultando in un mosaico che è difficile contenere in una narrazione lineare e riconoscibile come è accaduta invece per quella degli anni compresi tra fine Ottocento e primo Novecento.
L’ambivalenza dell’approccio alla memoria di Durastanti, messa in luce da questa contrastante identificazione con il memoir e con il novel, acquisisce un’ulteriore sfumatura di ambiguità nella scelta del titolo americano, Strangers I know, che ci spinge a interrogarci su quanto è lecito e possibile conoscere degli estranei, ma anche sui limiti della nostra conoscenza delle persone che pensiamo di conoscere e quanto in loro ci resta straniero, che descrive l’aspetto più profondo della riflessione portata avanti dall’autrice. Al lettore di lunga data di Durastanti, inoltre, il volume sottopone un ulteriore momento di confusione, introducendo un cambio di rotta piuttosto radicale nella carriera di un’autrice che in precedenza si era segnalata come pregevole traduttrice di letteratura statunitense nonché autrice di narrativa. In realtà, il mondo narrativo e quello autobiografico dell’autrice si comprendono nelle loro sovrapposizioni, e allora ha senso ritrovare pensieri di Chloe e di Caterina/Cleopatra, entrambi personaggi femminili con nomi che iniziano per C, in quelli riportati dalla voce narrante di Claudia nel volume più recente, e leggere le storie dei suoi personaggi che raccontano la loro adolescenza americana in cui risuona la dislocazione di una bimba che cerca gli Stati Uniti, nel momento in cui diventano “il paese di una sola stagione all’anno”, nelle rotonde e nelle abitudini degli abitanti del paesetto lucano prima e della capitale più tardi, nel momento in cui si iscrive alla facoltà di antropologia.
Un ulteriore elemento che rende così interessante questo lavoro di Durastanti, in particolare per il pubblico italoamericano o americano, è la modalità in cui l’esperienza della migrazione viene descritta in tutte le sue diverse possibilità e rappresentazioni – la prima, “grande” migrazione di massa; la migrazione post-guerra; la narrazione del ritorno; infine, quella della “fuga dei cervelli” – in un’opera la cui complessità risulta proprio da questo continuo oscillare tra la memorialistica e l’invenzione, un elemento che ritroviamo in un celebre classico quale Mount Allegro di Jerre Mangione, celebre rappresentante della prima generazione di autori italoamericani capace di affermarsi come scrittore in entrambi i paesi. Nella narrazione preponderante della dimensione familiare su cui si costruisce in dialogo la ricerca della propria voce individuale riconosciamo anche il Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, di cui questo libro raccoglie l’eredità anche offrendosi come riflessione sulla natura del linguaggio parlato nel contesto familiare. In realtà però, e in ciò risiede un ulteriore fattore di originalità, il linguaggio descritto da Claudia si caratterizza per essere un linguaggio non parlato, essendo i genitori dell’autrice entrambi affetti da sordità, argomento che emerge come periferico, all’inizio del libro, ma che poi si rivela come cruciale nella riflessione sulla lingua ibrida della famiglia estesa dell’autrice che, sospesa tra le due sponde dell’Oceano, oscilla tra l’inglese e l’italiano e tra lo statuto del dire e del non dire. Anche da questo punto di vista, l’esperienza di Claudia si caratterizza in modo originale in un affresco della diaspora italiana che è necessario fotografare nella sua molteplicità.
Ma se di Ginzburg Durastanti raccoglie la vocazione memorialistica e il desiderio di descrivere il linguaggio speciale che si parla tra i membri per decostruirlo, il senso di apocalisse e disfacimento che spesso affiora nel libro è genuinamente americano, nel senso più letterario, e sembra attingere dalle pagine più intense di Joan Didion, per esempio nelle descrizioni di Coney Island o dell’arrivo dell’autrice a Londra, e così il “lessico famigliare” si avvolge intorno a parole quali migrazione, sradicamento, disfunzione, eccesso, ma anche colore, tenerezza, identità, determinazione, enfatizzando una capacità di leggere l’affetto e il legame come sentimenti che ci uniscono attraverso il sangue che scorre uguale nelle nostre vene al di là del paese in cui ci collochiamo e di raccontare anche il tragico smorzandone i toni anche nei momenti più cupi.
Riprendendo un’intervista a cui ho sottoposto l’autrice nel periodo della prima uscita del libro, a tre anni di distanza e dopo numerose riletture, anche in quest’occasione rifiuto di prendere posizione per valutare se La straniera sia il libro più bello dell’autrice o quello più autobiografico, ma ribadisco la convinzione che si tratti del libro che descrive meglio, attraverso il racconto dell’instabilità di una famiglia tipica nella sua atipicità, un paese colto in una delle pagine più confuse della propria storia. Da questo punto di vista, Claudia esplora il memoir non solo come diario personale, ma anche come capitolo di una narrazione più estesa, che si fa familiare ma anche generazionale e transnazionale.
Tuttavia l’aspetto più sensazionale – nonché transnazionale – che viene fuori da questo libro è l’umanità della scrittrice, che si esplora senza riserve e senza giudicarsi, esponendo le proprie “ragioni sbagliate” e le difficoltà a collocarsi e relazionarsi al di qua e al di là delle difficoltà linguistiche. Da questo punto di vista, leggere La straniera mi ha fatto spesso pensare a La strada per Los Angeles di John Fante, il libro forse più sofferto e travagliato di un autore che è diventato un classico raccontando proprio le sue ragioni sbagliate, senza tenersene nessuna, continuando a riproporsi sulla pagina attraverso le proprie imperfezioni e le sue questioni irrisolte anche quando era capace solo di dettare i propri pensieri dal letto di morte. The Road to Los Angeles, tra i romanzi di Fante, è indubbiamente quello più sbagliato, avviato nel 1933, terminato nel 1936 e pubblicato per la prima volta solo nel 1985, pochi anni dopo la morte dell’autore, quello che sarebbe dovuto essere il primo volume del ciclo di Arturo Bandini e che invece è stato sostituito dal più celebre Ask the Dust – Chiedi la polvere – celebrando sullo schermo, per quanto in una trasposizione discutibile, il sogno di scrittore inseguito da Fante in una vita intera, che lo ha portato a Hollywood come romanziere piuttosto che nel ruolo di sceneggiatore su cui aveva ripiegato.
Allora, leggendo Durastanti come Fante, abbiamo la sensazione di poter comprendere la diaspora italiana solo interrogandone anche gli aspetti irrisolti e gli sbagli, le pennellate sbilenche e il fondo della tela che emerge nei punti in cui la vernice si è scrostata nel tempo, pagina dopo pagina a partire dalle prime rappresentazioni a quelle più recenti, di cui La straniera sembra non lasciarne fuori nessuna.
In copertina: illustrazione di Massimo Carulli