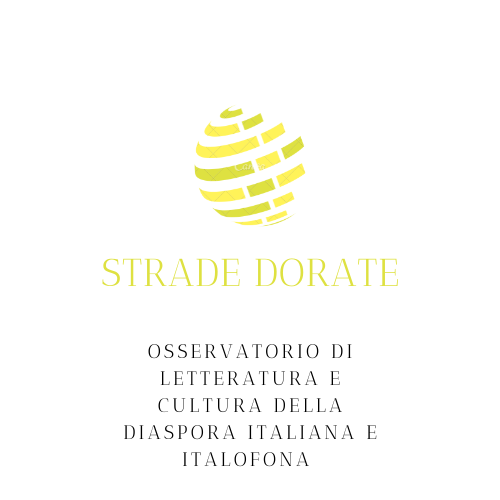di ANNA ALONZO
Anna Domenica detta “zia Bice” tornava in Abruzzo a trovare le cognate, solitamente nei periodi estivi, con suo figlio Enrico, un ragazzino brillante e gioioso, con alcune disabilità, a cui lei badava con estrema premura. Era un viaggio lungo e faticoso: partivano dal Canada con valigie quasi vuote, le avrebbero riempite poi con souvenir abruzzesi di ogni tipo, affrontavano un viaggio carico di non poche difficoltà e grandi aspettative. Enrico ha imparato tutto da quelle traversate e quando zia Bice non c’è stata più, lui ne ha organizzate altre, sempre ad Atri, cittadina abruzzese da cui suo papà Antonio e sua mamma Bice partirono circa settant’anni fa.
Oggi gli parlo, un po’ in inglese e un po’ in italiano, e gli chiedo proprio di quel giovane Antonio Bonomo: perché decise di lasciare Atri?
Entrambi i miei genitori erano figli di mezzadri, vivevano in una fattoria e coltivavano i terreni per il proprietario, in cambio di una parte di ciò che raccoglievano. In Abruzzo le possibilità erano scarse e ai tempi dei miei genitori non c’erano molte opportunità oltre al lavoro in fattoria.
Mio padre prestò servizio militare, come prevedeva la legge poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Viveva con sei sorelle e sentiva il bisogno di trovare qualcosa di meglio. Partì quindi per il Belgio, dove lavorò come operaio nelle miniere di carbone. Mandava regolarmente a casa i soldi guadagnati mano a mano, con quel lavoro stancante e usurante. Mi raccontava sempre però che, quando tornò ad Atri, si aspettava che gli venissero restituiti i soldi che aveva mandato, almeno in parte, ma non c’erano più: suo padre li aveva usati per pagare la dote di matrimonio di una delle sue sei figlie. Mio papà a questo punto, arrabbiato, pensò di andarsene di nuovo, ma questa volta per sempre.
C’erano già stati litigi e incomprensioni, tanto che a furia di vivere con un gruppo di donne e un papà severo, mio padre aveva imparato a dormire nella stalla, con le mucche, quando l’aria non era tranquilla e c’era qualche discussione. Ma quella volta era diverso, raccontava che un giorno, camminando con suo padre fino al confine dei terreni della fattoria, gli restituì i suoi stivali da lavoro e gli disse addio: papà Antonio avrebbe lasciato l’Abruzzo e le sue colline, la fattoria e la vita di campagna, e arrivato a Toronto, non sarebbe veramente più tornato.
Da ragazzino, nel 1967, io stesso ho visitato la sua fattoria, quello che ne era rimasto, guardando l’orizzonte che lui stesso osservava anni prima e ho immaginato la sua voglia di vivere e di riscatto, di voler dimostrare alla sua famiglia che c’era un mondo oltre le colline di Atri. In quei giorni, ho passato dei momenti molto divertenti con mia zia Adalgisa, lì ero in pace.
Tuo papà quando decise di partire?
Mio padre arrivò a Toronto il 2 febbraio 1956 e io nacqui il 5 novembre dello stesso anno. Mia mamma era arrivata in Canada con la sorella Italia nel 1954, accolta dalla sorella maggiore Maria e da suo fratello Alfredo. Entrambi trovarono lavoro: mia mamma in una lavanderia e Zia Italia in un panificio. Mamma e papà si conoscevano fin dai tempi in cui vivevano da Atri e si sposarono “per procura” nel novembre del 1955.
E’ stato difficile per loro ambientarsi in Canada?
Era molto difficile vivere in Canada. Né mamma né papà parlavano una parola di inglese, anche Zia Maria e Zio Alfredo, nessuno di loro aveva un’istruzione formale, avevano frequentato appena la prima elementare. Il più “esperto” era lo zio Alfredo: lui fu prigioniero durante la seconda guerra mondiale in Inghilterra e lì, lavorando in una fattoria, aveva imparato alcune frasi di base.
Lo zio Alfredo era considerato il “patriarca” della famiglia in Canada. Una delle prime cose che ha insegnato a mia mamma, papà e zia è stata la frase “Ho bisogno di un lavoro”, probabilmente erano le parole più importanti in quei primi giorni di confusione e di paura. Per tanto tempo non avrebbero imparato altre parole, cercando di intuire significati di sguardi, espressioni, gesti. Ricordo ancora che mia zia Italia mi raccontava sempre, fino agli ultimi suoi giorni di vita, una storia risalente all’epoca in cui lavorava in questa specie di forno, un donut shop: il suo capo continuava a dire qualcosa che non riusciva a capire. Passarono tanti mesi prima che lei scoprì che lui le stava dicendo “Non bere mai il mio caffè”. Quando ne scoprì il significato, ne rimase infastidita: non aveva mai potuto rispondergli.
Che tipo di lavoro aveva in Canada tuo papà?
Come ho già detto, nessuno dei miei genitori aveva alcuna istruzione formale, quindi mio padre ha lavorato tutta la sua vita in Canada come operaio. All’inizio lavorava con picconi e pale insieme a molti altri immigrati italiani. Col passare del tempo divenne membro del sindacato operaio, l’impegno per una maggiore sicurezza sul lavoro lo ripagava. Con gli anni, riuscì a mettere da parte i soldi per comprare una casa, sicuramente vivevamo comodamente ma mai da benestanti, sempre con estrema parsimonia poiché mamma non lavorava: ero un bambino disabile e lei ha passato tutta la sua vita a prendersi cura di me.
C’era già una bella comunità di italiani a Toronto?
La comunità italiana si espanse enormemente dopo la seconda guerra mondiale, ma nonostante fossimo in tanti c’erano comunque molte discriminazioni da parte dei Canadesi e tante difficoltà per noi nell’orientarci in un mondo che era sempre estraneo: non c’era una grande disponibilità di traduttori nella maggior parte delle istituzioni (banche, uffici governativi, ospedali). Quelli nella nostra comunità, che erano molto pochi, hanno agito sia come traduttori che come avvocati veri e propri, cercando di sostenerci e di aiutarci a fare chiarezza tra regole e leggi sconosciute.
Abbiamo avuto la fortuna di avere come padroni di casa due sorelle che hanno aiutato mamma e papà ad affrontare le complicazioni dovute al fatto che la mia nascita era, come dire? Insolita! Loro pagarono il conto dell’ospedale per riportarmi a casa e organizzare i servizi “speciali” allora disponibili per i bambini con disabilità. Le padrone di casa sono state determinanti per i miei genitori, che avevano il grande desiderio che il proprio figlio potesse far parte della famiglia e riuscisse ad integrarsi nella comunità invece di essere accudito all’esterno, magari in una casa di cura.
Com’è stata la tua vita da italiano di prima generazione in Canada?
Credo che la mia esperienza sia unica, data la mia disabilità. Era consuetudine che il bambino, frequentando la scuola e conoscendo un inglese più standard, fungesse da portavoce dei suoi genitori. Anche a me fu assegnato quel ruolo perché non avevo fratelli, ero l’unico in casa che potesse aiutare i miei genitori. Mi ricordo scene molto particolari e inconsuete: un bambino di 9 anni portato nello studio di un dottore per tradurre! Un bambino con disturbo del linguaggio e spasticità per di più, davvero insolito! Non ero agevolato, è chiaro, ma i miei genitori hanno insistito. Credo che sia stato un avvenimento unico.
Alla maggior parte dei figli di italiani immigrati è stata garantita un’istruzione ben oltre quella dei loro genitori. Credo di essere stato il primo tra tutti i cugini a laurearsi all’università, facoltà di Economia e Commercio! Non male per una persona spastica e con difficoltà di parola, spesso la gente ipotizzava fossi ritardato, un po’ per i miei problemi oggettivi, un po’ perché figlio di immigrati. La perseveranza dei miei genitori diede dei frutti anche oltre le loro migliori speranze.
Una volta che ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare, la vita è diventata molto più semplice. Siamo stati in grado di vivere in maniera meno frugale, ci siamo tolti qualche sfizio. Ho potuto viaggiare per il mondo e andare a fare visita alla famiglia di Atri ogni due o tre anni.
Hai mai seguito corsi di italiano?
Ho seguito alcuni corsi di italiano ma l’italiano è comunque la mia lingua madre, un italiano toccato da modi di dire abruzzesi: ho imparato a parlare il dialetto atriano da bambino. Gli insegnanti dei miei corsi serali continuavano a tormentarmi affinché smettessi di usare il dialetto e seguissi l’italiano moderno. Ma io sono cresciuto così, l’italiano per me era una terza lingua ancora, che io capivo ma parlavo a mala pena.
Una storia che zia Adalgisa ama raccontare quando vado a trovarla è quella di quando eravamo insieme nella fattoria e mi chiese se avevo mai visto una mucca. Le dissi di no, non sapevo cosa fosse, così lei me l’ha mostrata e in quel momento ho detto “ah, ma è ‘na vacc!”. Cinquanta anni dopo scherza ancora con me su questo episodio: io conoscevo solo la forma dialettale di “vacca”, alla quale non avevo mai associato il termine “mucca”.
Conosci qualche figlio di emigranti italiani che si è poi laureato in lingua e letteratura italiana?
Da parte di mia madre, una figlia di mia cugina ha una laurea in traduzione italiana e purtroppo non ha potuto intraprendere la relativa carriera. Un’altra famiglia di Atri ha una figlia che ha studiato italiano all’università e ora lavora in una banca e ha la capacità di servire i clienti di lingua italiana nella loro lingua madre.
Cosa pensavano i tuoi genitori dell’Italia? Cosa gli è mancato di più? Hanno mai detto di voler tornare in Italia?
Ogni immigrato ha dei momenti in cui desidera poter tornare nel proprio paese d’origine. Molte volte ho sentito mia madre dire che se avesse avuto i soldi qualche settimana dopo il suo primo arrivo in Canada sarebbe tornata indietro. Ci sono diverse le famiglie di Atri che sono tornate dopo anni trascorsi in Canada. La maggior parte degli immigrati ritiene che l’aspetto più difficile nel trasferirsi in Canada sia la mancanza di conoscenza della lingua inglese o francese.
Sono profondamente consapevole della benedizione che ho ricevuto per essere qui dove sono oggi. Sia mamma che papà hanno fatto sacrifici immensi per darmi opportunità che molte altre persone con disabilità non sono state in grado di ottenere.
Non ho mai avuto figli miei. Ma la maggior parte della mia generazione ha figli che sono diventati dottori, avvocati, architetti e diversi altri professionisti. Negli ultimi dieci anni mia moglie Denise e io abbiamo supportato alcune associazioni che si occupano di immigrazione di rifugiati, recentemente abbiamo supportato una famiglia del Burundi. Questo è il nostro quinto ciclo e cerchiamo sempre di convincere queste persone che non si tratta di loro o dei loro figli, ma della futura seconda generazione che farà grandi passi avanti per la società canadese e che contribuirà notevolmente al futuro di questa nazione. Il governo del Canada riconosce la loro situazione e dispone di politiche, programmi e servizi per consentire il successo di certe azioni. Come ogni altra nazione, anche in Canada abbiamo persone più spaventate dagli immigrati, il che porta a discriminazioni e ingiustizie. Gli immigrati italiani dal 1954 hanno superato certi stereotipi e sono sicuro che i nostri immigrati attuali avranno la stessa sorte.
Anna Alonzo è laureata in Storia d’Europa e vive a Bologna, dove insegna italiano per stranieri e si occupa di formazione. È una grande appassionata di lingua e cultura Italiana e letteratura, anche per l’infanzia.